La vita grama dell’elettore che non vende più l’anima
di Massimo Fini - 29/10/2025
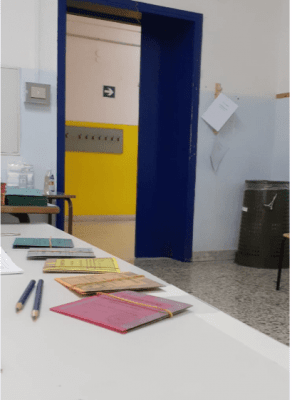
Fonte: Massimo Fini
Si alzano lai sempre più angosciati e ripetuti sulla mancata partecipazione dei cittadini alle elezioni e conseguenti anatemi su chi non è andato a votare, gli astensionisti. In Toscana, dove la partecipazione è sempre stata forte perché conserva un nucleo duro di simpatizzanti del Pci oggi Pd – i “trinariciuti” come li chiamava Giovanni Guareschi – ha votato solo il 48% alle Regionali. Ma è solo un esempio. È da anni che l’astensionismo è in costante crescita.
Cominciamo col dire che l’articolo 48 della Costituzione definisce il voto un “dovere civico”, non votare non è quindi un obbligo di legge. Io sono libero di votare o di non votare secondo il mio convincimento. Scrive a proposito del voto d’opinione Norberto Bobbio, sulla cui patente democratica non è lecito dubitare: “Oserei dire che l’unica vera opinione è quella di coloro che non votano perché hanno capito, o credono di aver capito che le elezioni sono un rito cui ci si può sottrarre senza danni” (Sudditi, Manifesto contro la Democrazia, pag. 54). Del resto la democrazia in tempi moderni non è mai stata una democrazia. Fa eccezione in antiquo la Grecia di Pericle che comunque copre un periodo relativamente breve di tempo, circa due secoli, e che fu, a differenza dei tiranni, particolarmente bellicista perché voleva imporre la democrazia a tutte le altre polis – c’è qui in nuce quello che ho chiamato “il Vizio oscuro dell’Occidente” –. C’è da notare anche che la decadenza di Atene comincia proprio quando cercò di imporre la sua cultura politica alle altre polis, un monito che vale oggi per tutto l’Occidente e in particolare per gli americani.
In realtà la democrazia attuale non è una democrazia ma una partitocrazia, un’oligarchia, come la chiama pudicamente Giovanni Sartori, gruppi di potere e di pressione che finiscono per concentrarsi in qualche partito. Nonostante la nostra Costituzione nomini i partiti in un solo articolo (l’art. 49 stabilisce che “tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale con metodo democratico”), ma uscendo da questa loro funzione i partiti hanno finito per occupare tutti gli spazi della vita pubblica e anche privata. Del resto è ovvio. All’affermazione di Bobbio sulla libertà di opinione si contrappone ancor più duramente la scuola ‘elitista’ italiana di fine Ottocento. Scrive Gaetano Mosca ne La classe politica: “Cento che agiscano sempre di concerto e di intesa gli uni con gli altri trionferanno su mille presi uno a uno che non avranno alcun accordo tra di loro”.
I partiti sono in realtà delle cosche mafiose, ne hanno la mentalità, che utilizzano tutti i metodi della mafia a eccezione dell’assassinio, ma non sempre (caso Ambrosoli). Insomma vale ancora quello che scrisse, durante il regime fascista, in Vino e pane Ignazio Silone: “Per vivere un po’ bene, bisogna vendere l’anima. Non c’è altra soluzione”. Altrimenti ci si deve rassegnare a una vita grama.
La situazione non è cambiata, se non in peggio. Paradossalmente durante il Fascismo esisteva ancora una Magistratura indipendente tanto che per i reati politici il Fascismo dovette inventarsi dei “tribunali speciali”. Oggi non è che la Magistratura, nel suo complesso, non sia indipendente, però i singoli magistrati sono divisi in correnti che fanno riferimento, almeno dal punto di vista ideologico, a questo o a quel partito. Ci sono addirittura casi in cui un uomo politico è diventato magistrato per poi tornare a fare il politico (le cosiddette “porte girevoli”). Ora il magistrato, come la moglie di Cesare, non solo deve essere onesto ma deve anche apparire onesto, nella fattispecie non dipendere da nessuna ideologia che si richiami a un partito. Tra i pochi magistrati a non militare in nessuna corrente ricordo Antonio Di Pietro (divenuto politico solo dopo aver lasciato la toga), che Allah l’abbia sempre in gloria, e oggi Nicola Gratteri. Oggi assistiamo a un attacco frontale nei confronti della Magistratura da parte delle Destre e dei “berluscones” di tutte le risme, e questo si capisce, ma anche se un politico di sinistra viene colto con le mani sul tagliere si comincia a parlare di complotti. Ora è ovvio che le sentenze si possano criticare fino a quella definitiva della Cassazione, ma da qui a parlare ogni volta di ‘complotto’ il passo è troppo lungo. Oggi insomma non c’è rispetto non solo per i singoli magistrati, ma nemmeno per la Magistratura, che insieme all’esecutivo (il governo) e al legislativo (Parlamento) è, nella classica distinzione di Montesquieu, uno dei tre organi fondamentali in uno Stato di diritto. Devo dire che un vero rispetto per la Magistratura lo dimostrarono Giulio Andreotti e Arnaldo Forlani. I quali, a differenza di Berlusconi e di tutti i berluscones della terra si difesero sempre all’interno del processo, non proclamando mai di essere vittime di un qualche complotto. Perché una classe dirigente consapevole d’esser tale non delegittima le Istituzioni, perché sono le sue Istituzioni. Dal mancato rispetto delle Istituzioni germina l’anarchia che favorisce solo coloro che non hanno nulla da perdere, per dirla con Marx, se non le proprie catene (io sono favorevolissimo all’anarchia, ma questo discorso ci porterebbe troppo lontano e non può essere riassunto in un articolo, per quanto lungo).
Insomma non si tratta di avere una tessera di partito, questo solo i poveracci lo fanno, così come non esistono più puttane che esercitino sulla strada. Si tratta di avere un’appartenenza che si rifà a questo o a quel partito.
Ma torniamo a cose dell’oggi. Perché sono in crisi i partiti? Perché hanno perso i contatti con i cittadini. Un tempo esistevano le sezioni del Pci, del Psi, le parrocchie e anche centri culturali di tutto rispetto, come la Casa della Cultura di derivazione comunista o il Circolo Carlo Rosselli, socialista. Poi c’erano, sempre a Milano, bar, pub, ristoranti dove potevi incontrare uomini di cultura o musicisti come il Santa Tecla o il Derby, dove arrivavano solo i migliori, Jannacci, Gaber. C’era il Jamaica o il meno noto Oreste, in piazza Mirabello, dietro il Corriere. È da Oreste che ho incontrato Umberto Eco che, fra una partita di boccette e l’altra, mi regalò quello che per me resta il suo saggio più importante: Fenomenologia di Mike Bongiorno. Perché Eco è grande come sociologo, non come romanziere (Il nome della Rosa, Il pendolo di Foucault) per la solita ragione: il sociologo, ma anche il giornalista, affronta la realtà con lo spirito del cronista, mentre nel romanzo, che gioca sulla fantasia, lo sfumato o addirittura il non detto è più importante del detto. Non ci sono giornalisti che siano stati anche grandi romanzieri. Anche Buzzati che è grande sulla lunghezza del racconto, in Un Amore, dove tenta la via del romanzo, fallisce (Hemingway e Fitzgerald fanno storia a sé che si lega all’importanza delle riviste culturali dei primi del Novecento).
Questa distanza dei politici dai ‘cittadini comuni’ è particolarmente evidente nelle grandi città. Chi a Milano ha mai visto un politico in carne e ossa? Non li vedi nei cinema, nei bar, a teatro, in piazza. I politici si fanno vedere semmai alla Prima della Scala, perché è un evento così prestigioso che può essere utile per farsi pubblicità. Per anni, gli anni di Craxi, la Scala è stata un feudo dei socialisti. Proprio non ci potevi entrare se non avevi la tessera o non eri aggregato a quelli della “Milano da bere”. Comunque, lasciando perdere Craxi, nel periodo in cui i sindaci erano socialisti, Aniasi, Tognoli, il “cognatissimo” Pillitteri, per sentir musica dovevi andare ai festival o alle rassegne musicali di Como. Altro che “Milano da bere”.
