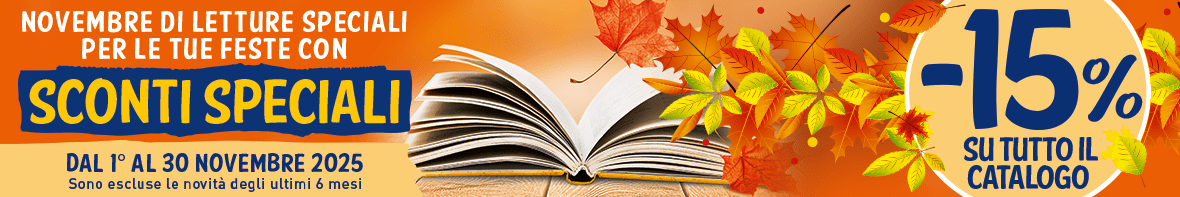Le guerre di aggressione della Nato nel Vicino Oriente
di Giancarlo Chetoni - 17/06/2011

Lettere su un reportage completo sulla guerra della Nato alla Jamahiriya per il solo arco dell’ultimo mese è lavoro complesso ma necessario a far capire lo spessore criminale degli attori che si muovono nell’ombra e allo scoperto sulla scena “internazionale” per portare a termine la disintegrazione di uno Stato Nazionale con la manifesta finalità di impadronirsi con la forza dei suoi assets finanziari e della sua ricchezza energetica usando come paravento la risoluzione Onu 1973. Una risoluzione vomitata, con la complicità di Ban Ki Moon, da “presidenze” screditate, monarchie ereditarie, dittatori ladri e Paesi “fantoccio” con la sorprendente astensione di Russia e Cina.
Una risoluzione che legittima, si fa per dire, il via libera ad un nuovo terremoto geopolitico ed economico di portata continentale nel tentativo di garantire la sopravvivenza nel XXI secolo di un Occidente ormai largamente marginale nell’intera Asia, nell’America Indio Latina e in larga parte dell’Africa, traballante nel Vecchio Continente, corroso e in liquidazione a tappe forzate sul piano finanziario, bancario, industriale, commerciale e sociale nella stessa America del Nord.
Il ricorso ormai continuativo, parossistico, alla forza di Usa (o Alleanza Atlantica) dal Kiber Pass al Mediterraneo è l’ultimo, disperato, tentativo di fermare con la forza delle armi e della propaganda il profilarsi dell’inarrestabile declino a livello planetario della politica delle “cannoniere”, di nuovi colonialismi stragisti abbondantemente annaffiati dalla teorizzazione dell’odio di “civiltà”.
La Nato che nei piani delle amministrazioni e dei segretari alla Difesa avrebbe dovuto affiancare gli Usa in Afghanistan e in Iraq per rendere meno traumatici i costi delle guerre di aggressione e il logoramento del personale militare del Pentagono in Asia e Vicino Oriente, alla prova dei fatti, sul terreno, ha evidenziato una inaspettata intrinseca incapacità di arrivare a contenere qualsiasi forma organizzata di guerra “asimmetrica” portata avanti anche da forze “ostili” numericamente esigue oltre che impreparate a sostenere un contrasto militare “convenzionale”.
In Afghanistan a fronte di 405 mila tra soldati Isaf, polizia ed esercito dell’ “esecutivo” Karzai l’iniziativa tattica rimane, ancora oggi, saldamente nelle mani dell’etnia pashtun che ha sul campo non più di 18-20mila “combattenti-straccioni”, mentre in Iraq la guerriglia del Baath e dell’esercito del Mahdi, 30 mila militanti in tutto, armati di vecchi Ak 47 e qualche Rpg, ha tenuto sulla corda, fino allo stallo attuale, dal 2003 al 2009, oltre 500 mila militari e paramilitari di Usa, Nato e del “governo” Al Maliki.
Risultati che a ben vedere si ripetono non dissimili su tutti i teatri di guerra aperti dall’imperialismo Usa nel mondo a partire dalla guerra del Vietnam, con un’unica eccezione: l’invasione dell’Isola di Granada (344 kmq di territorio, operazione Urgent Fury del 15 dicembre del 1983) dove la preponderanza numerica (15 a 1) della forza di invasione a stelle e strisce ebbe ragione in breve tempo dei 250-300 isolatissimi, anche dalla Repubblica di Cuba, combattenti locali dell’Mrc di Bernard Coard.
Se ci domandassimo quali fattori “strategici” giochino contro “l’imperialismo” dovremmo darci una risposta necessariamente complessa che richiederebbe una lunga analisi.
Sintetizzando si può affermare che entrano in gioco elementi principali e secondari. Tra i primi, in breve, l’estensione in kmq dei territori oggetto di aggressioni armate che finiscono per diluire l’efficienza sul campo delle forze militari straniere, le difficoltà di trasferimento, di stazionamento e di rifornimento logistico degli invasori, le differenze linguistiche, culturali, religiose, di organizzazione sociale e di ambientamento climatico, congiuntamente alla diversa determinazione al combattimento, al sacrificio, tra “occupanti” e “occupati”.
Insomma il Sudan di Ahmad al Bashir, con o senza Darfur, con o senza mandato di cattura del Tribunale dell’Aja, nell’attuale contesto geopolitico globale, può dormire sonni enormemente tranquilli, come lo potrà essere il nuovo Yemen uscito dal dopo Saleh, un altro Mubarak “liquidato” (ferito, morto?) e misteriosamente inghiottito dal deserto wahabita dei Saud come il tunisino –arciladro - Ben Alì.
Un Paese, lo Yemen, che è rapidamente avviato nel cono d’ombra dei media “occidentali” dopo le colossali manifestazioni di popolo: cinque milioni gli uomini e le donne nelle vie e nelle piazze di Sanaa, che hanno acclamato la partenza senza ritorno di Saleh dopo la fuga precipitosa degli ambasciatori e funzionari di Usa, Gran Bretagna e Francia.
Dove lo abbiamo visto e saputo? Dalle foto e dai comunicati di Itar Tass.
Intanto Tremonti mente o si illude quando afferma che la “democrazia” imboccata dai popoli del Vicino-Oriente arriverà presto in Asia. Il prossimo sbarco sarà sulle coste dell’Adriatico e a tempi più lunghi sulle sponde sud dell’Europa Mediterranea, quando sarà stato spazzato via, sotto il peso di una devastante crisi economica e sociale, il collaborazionismo politico e sindacale di vertice, sia a livello nazionale, che europeo.
La Siria di Bashar al Assad, per chi la conosce a fondo, è uno Stato dotato di un sistema politico e militare saldissimo, a prova di Facebook, di Twitter, Al Jazeera e al Arabya, di attacchi “curdi” e di “opposizioni interne” finanziate da Usa e “Israele” e propagandate in voce e in immagini nella Repubblica delle Banane dal funzionario di turno della Rai, o da quello in servizio permanente effettivo a “Gerusalemme” Claudio Pagliara.
La Siria dovrà far fronte sia alle forze Usa che stazionano sul confine con l’Iraq che ad attacchi che possano indebolire la sua tenuta militare a ridosso del Golan occupato dall’entità israeliana dal 1967. Quello che Usa e Nato vorrebbero realizzare è un alleggerimento geopolitico sulla morsa che si sta stringendo sull’ “unica democrazia realizzata” del Vicino Oriente. La vittoria plebiscitaria ottenuta da Erdogan in Turchia suona anche di fatto come un’altra sonora sconfitta per l’Occidente.
Le pressioni occidentali sulla Siria si esauriranno nei prossimi due-tre mesi. Medvedev ha dovuto pubblicamente confessare agli “amiconi” del G8 che non sarà in grado di ripetere con Damasco l’operazione Tripoli attuata con il suo inviato “ speciale “ per l’Africa Margelev. Notizia diffusa da Ria Novosti.
La Russia “profonda” sembra aver rinunciato momentaneamente a tutelare i suoi enormi interessi commerciali in Libia per salvaguardare il principio gerarchico dell’ “autorità” del presidente pro-tempore e mettere nel contempo alla prova la tenuta “militare” di Unified Protector…
Quando rientrerà la “rivolta araba”, in ogni caso, i rapporti di forza nel Medio Oriente non saranno più gli stessi.
E la Jamahiriya di Gheddafi?
Beh, qui c’è da temere il peggio su tempi medio-lunghi.
L’Occidente vuole inghiottire la Libia non solo per impossessarsi delle sue risorse finanziarie ed energetiche ma anche per avere un governo fantoccio ai confini tra Egitto e Tunisia e basi di cacciabombardieri a un tiro di sputo dal Canale di Suez e dall’Algeria di Bouteflika.
Trapani Birgi è troppo lontana dai targets della Jamahiriya come lo sono Akrotiri e Dhekelia nell’isola di Cipro.
Particolare curioso: perché gli aerei d’attacco della Gran Bretagna non possono decollare da Trapani Birgi come quelli della Francia del “divo” Sarkozy? Perché le basi Nato in Italia, per l’operazione Unified Protector, sono solo a disposizione dell’AM.I e dell’Us Air Force e agli Alleati, di poco peso, quelli cioè graditi all’Amministrazione Obama? Obama ha ottenuto da Berlusconi, Frattini e La Russa l’ “esclusiva”?
Se non ci fosse da piangere ci sarebbe da ridere.
Per un analisi più approfondita dovremo aspettare di capire l’impatto militare sulle forze del Colonnello che otterranno gli elicotteri da combattimento di Francia e Inghilterra sia sulla Litoranea, in prossimità di Misurata, che lungo la fascia costiera Tripoli-Marsa el Brega.